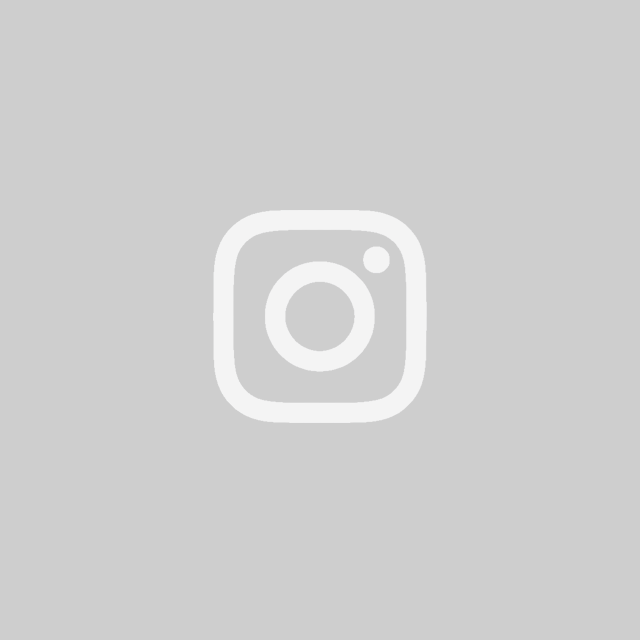Palazzo Te è un edificio monumentale di Mantova. Costruito tra il 1524 e il 1534 su commissione di Federico II Gonzaga, è l’opera più celebre dell’architetto italiano Giulio Romano. Il complesso è oggi sede del museo civico e, dal 1990, del Centro internazionale d’arte e di cultura che organizza mostre d’arte antica e moderna e d’architettura. Verso la metà del XV secolo Mantova era divisa dal canale “Rio” in due grandi isole circondate dai laghi; una terza piccola isola, chiamata sin dal Medioevo “Tejeto” e abbreviata in “Te”, venne scelta per l’edificazione del Palazzo che ne ha preso il nome. Due sono le ipotesi più attendibili sul significato del termine teieto (o tejeto): esso potrebbe derivare da tiglieto (località di tigli), oppure essere collegato a “tegia”, che significa capanna.
Storia
Le prime testimonianze in merito alla presenza della Fabbrica del Te si hanno nel 1526, quando viene citato un edificio in costruzione che sorge vicino alla città, tra i laghi, sulla direttrice della Chiesa e del Palazzo di San Sebastiano.
La zona risultava paludosa e lacustre, ma i Gonzaga la fecero bonificare e Francesco II la scelse come luogo di addestramento dei suoi cavalli. Suo figlio, Federico II, decise di trasformare l’isoletta nel luogo dello svago e del riposo e dei fastosi ricevimenti con gli ospiti più illustri, dove poter sottrarsi ai doveri istituzionali assieme alla sua amante Isabella Boschetti. Abituato sin da bambino all’agio e alla raffinatezza delle ville romane, incaricò l’architetto Giulio Romano e alcuni suoi collaboratori di realizzare la sua idea di “isola felice”. Alternando gli elementi architettonici a quelli naturali che la zona offriva, decorando sublimemente stanze e facciate, l’architetto espresse tutta la sua fantasia e bravura nella costruzione di Palazzo Te.
La simbologia del Palazzo
I simboli e gli stemmi riempiono di significati, più o meno celati e spesso politici, le pareti del palazzo. Il Monte Olimpo, ad esempio, che sorge dalle acque circondato da un labirinto, è un simbolo che spesso si ripete, e viene ripreso in elementi architettonici costitutivi del palazzo come le due ampie peschiere che attraverso un ponte portano al giardino, o come il labirinto in bosso (ormai scomparso) del giardino stesso.
Altro simbolo interessante è la salamandra, spesso associata al motto “quod huic deest me torquet” (ciò che manca a costui mi tormenta); il ramarro infatti era ritenuto l’unico animale insensibile agli stimoli dell’amore, ed era impiegato come contrapposizione concettuale al duca e alla sua natura sensuale e galante, che invece dai vizi dell’amore era tormentato.
La struttura architettonica
Il Palazzo è un edificio a pianta quadrata con al centro un grande cortile quadrato anch’esso, un tempo decorato con un labirinto, con quattro entrate sui quattro lati. Le proporzioni sono insolite: si presenta come un largo e basso blocco, a un piano solo, la cui altezza è circa un quarto della larghezza. Il complesso è simmetrico secondo un asse longitudinale.
Sul lato principale dell’asse (a nord-ovest) l’apertura di ingresso è un vestibolo quadrato, con quattro colonne che lo dividono in tre navate. La volta della navata centrale è a botte e le due laterali mostrano un soffitto piano, assumendo così una conformazione a serliana estrusa.
L’entrata principale (a sud-est) verso la città e il giardino è una loggia, la cosiddetta Loggia Grande, all’esterno composta da tre grandi arcate su colonne binate a comporre una successione di serliane che si specchiano nelle piccole peschiere antistanti. La balconata continua al secondo registro, sulla parte alta della facciata; in origine si trattava di una loggia: questo lato del palazzo fu infatti ampiamente rimaneggiato alla fine del Settecento, quando fu aggiunto anche il frontone triangolare che sormonta le grandi serliane centrali.
Le facciate esterne sono su due livelli (registri), uniti da paraste lisce doriche di ordine gigante. Tutta la superficie esterna è trattata a bugnato.
Il cortile interno segue anch’esso un ordine dorico, ma qui su colonne di marmo lasciate quasi grezze e sormontate da una possente trabeazione dorica.
Giulio Romano, ispirandosi ad un linguaggio architettonico classico, lo reinterpreta creando un’opera con un ricco campionario di di invenzioni stilistiche, reminiscenze archeologiche, spunti naturali e decorativi, che spiazzano l’osservatore e danno una sensazione di non finito all’insieme.
Pare che il palazzo fosse, in origine, dipinto anche in esterno, ma i colori sono scomparsi mentre rimangono gli affreschi interni eseguiti dallo stesso Giulio Romano e da molti collaboratori. Le pareti erano arricchite anche da tendaggi e applicazioni di cuoio dorate e argentate; le porte erano decorate con legni intarsiati e bronzi e i caminetti erano costituiti di nobili marmi.
I terremoti dell’Emilia del 2012 hanno provocato danni ad alcune sale del palazzo gonzaghesco.
Le sale del palazzo
Il Palazzo è suddiviso in numerose sale: Sala dei giganti, interamente decorata con l’affresco della Caduta dei Giganti; Sala grande dei cavalli, con i ritratti in grandezza naturale dei sei destrieri preferiti dei Gonzaga; Sala di Amore e Psiche, sala da pranzo del duca, interamente affrescata con la mitologica storia di Psiche, simbolo dell’amore del duca per Isabella Boschetti; Sala delle aquile, camera da letto di Federico ornata al centro della volta con l’affresco della caduta di Fetonte dal carro del sole; Sala dei venti o dello zodiaco; Sala delle imprese; Sala di Ovidio; Camera del Sole; Sala dei bassorilievi e Sala dei Cesari, salette chiaramente omaggianti l’imperatore Carlo V da cui Federico ottenne nel 1530 il titolo di duca; Loggia d’onore, loggia che si affaccia alle pescherie.
Museo Civico
Le occupazioni spagnole, francesi e austriache e le varie guerre fecero sì che nel corso degli anni il Palazzo venisse utilizzato come caserma e i giardini come accampamenti per le truppe, depauperando le sale e distruggendo alcune sculture. Nel 1866 la villa venne acquisita dallo Stato Italiano. Nel 1876 l’edificio divenne proprietà del Comune di Mantova.
Dopo parecchi restauri il palazzo restituisce oggi, con le sue sale e i giardini, un’incantevole tuffo nella creatività di Giulio Romano e nell’importanza della corte dei Gonzaga. Ulteriore scopo delle istituzioni cittadine era di ricavare in Palazzo Te un museo, affinché fossero ospitate almeno una parte delle collezioni civiche. Lo spazio espositivo permanente fu ricavato nelle sale al piano superiore. Quattro sono le collezioni esposte: Sezione Gonzaghesca, costituita da materiali legati prevalentemente alla storia mantovana di età gonzaghesca (1328-1707); Sezione “Arnoldo Mondadori”, costituita da diciannove dipinti di Federico Zandomeneghi e da tredici di Armando Spadini, raccolti da Arnoldo Mondadori e donati nel 1974 dagli eredi dell’editore di origine mantovana; Raccolta Egizia “Giuseppe Acerbi”; Collezione Mesopotamica “Ugo Sissa”, costituita da circa 250 pezzi d’arte mesopotamica databili tra la fine del VI millennio a.C. e la fine del I millennio d.C.