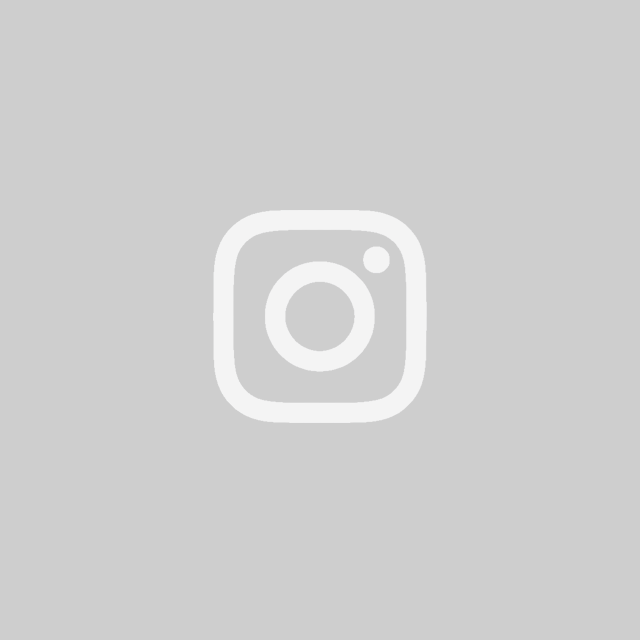La Biblioteca Nazionale Marciana (ovvero la biblioteca di San Marco), è una delle più grandi biblioteche italiane e la più importante di Venezia. Contiene una delle più pregiate raccolte di manoscritti greci, latini ed orientali del mondo. Nota anche come Biblioteca Marciana, Biblioteca di San Marco, Libreria Marciana, Libreria Sansoviniana, Libreria Vecchia o Libreria di San Marco, si trova sulla parte inferiore di Piazza San Marco, tra il Campanile di San Marco e la Zecca.
STORIA
La prima proposta per istituire una “pubblica libreria” a Venezia fu avanzata nel 1362 da Francesco Petrarca, che non riuscì tuttavia a realizzare il progetto. Alla sua morte, lasciò la sua biblioteca personale ai Da Carrara, signori di Padova. Il primo nucleo della biblioteca è costituito dalla donazione che il cardinale Giovanni Bessarione fece il 31 maggio 1468 allaRepubblica di Venezia “ad communem hominum utilitatem” (per il bene comune degli uomini): 746 codici, di cui 482 in greco e 246 in latino, cui si aggiunsero successivamente altri 250 manoscritti dopo la morte del donatore.La biblioteca incrementò il suo inventario grazie a numerose donazioni e lasciti, nonché grazie all’incorporazione di altre biblioteche della città e della Repubblica. Molte delle opere donate provenivano da Bisanzio, occupata dall’Impero Ottomano nel 1453. Anche grazie a questa raccolta, Venezia fu il più importante centro dello studio dei classici greci. Attirò i più grandi studiosi umanisti, molti dei quali riuniti attorno all’editore Aldo Manuzio nell’Accademia Aldina. Nel 1603 entrò in vigore una legge che impose a ogni stampatore veneto di depositare una copia di ogni libro stampato presso la Marciana, che divenne così la biblioteca istituzionale della Serenissima Repubblica. Dopo la caduta di Venezia, le raccolte di enti religiosi soppressi da Napoleone confluirono nella Biblioteca Marciana.Nel 1811 la biblioteca venne trasferita nel Palazzo Ducale. Solo nel 1924 tornò nella sua sede storica. Oggi occupa, oltre al Palazzo della Libreria, anche la Fabbrica della Zecca di Jacopo Sansovino.
FACCIATA
Jacopo Sansovino è chiamato a costruire un importante manufatto che ha il pesante compito di marcare un forte segno nella piazza, sempre da lui progettata ma anche quello di non sminuire il significato e il valore di essa: deve inoltre dialogare con le preesistenze. Il progetto è notevole, la struttura importante. La decorazione sta alla base della biblioteca, costruita su due piani. L’ordine architettonico, che definisce in modo significativo il decoro del manufatto, è sovrapposto, vale a dire che troviamo al piano terra un ricco dorico tridimensionale che è appoggiato ai pilastri (alla romana) con triglifi e metope evidenti e al piano superiore lo ionico. Esempio di grande innovazione sono le serliane molto compattate che al piano primo caratterizzano l’edificio.L’arricchimento decorativo della biblioteca è impreziosito con opere sculturee (non si dimentichi che lo stesso Sansovino era uno scultore e mette in questo caso a frutto le sue abilità). Festoni di frutta, un grande cornicione con statue importanti in corrispondenza delle colonne caratterizzano l’evidente coronamento rinascimentale. Per la prima volta notiamo lo svuotamento dei parapetti proprio sul coronamento, novità assoluta per la biblioteca. Oltre all’innovazione, tutto è pensato in riferimento ai modelli romani, come ad esempio i festoni che erano usati nelle opere funerarie romane. Palladio definisce la biblioteca “l’edificio più ricco e più ornato che si sia mai fatto dagli antichi fin qua”. La facciata è su due livelli:- le arcate del piano terreno sono di ordine dorico. Su di esse poggia una trabeazione dorica che alterna triglifi e metope;- al secondo livello si trova un loggiato di ordine ionico, sovrastato a sua volta da un ricco fregio in cui si susseguono putti e festoni di fiori e frutta. Nei sottarchi, una ricca decorazione scultorea. Sul coronamento, una balaustra sormontata da statue di divinità classiche, opera di Alessandro Vittoria e di altri noti artisti. Nella facciata, leggera e chiaroscurata, i vuoti prevalgono sui pieni. Si tratta di un organismo polivalente, il cui prospetto sulla piazza è risolto con un doppio ordine di arcate a carattere romano, ispirate al Teatro di Marcello e ai progetti sangalleschi per il cortile di Palazzo Farnese, ma le alterazioni delle proporzioni denunciano una volontà di interpretazione che va oltre la citazione accademica. Il primo ordine, porticato, riprende il doppio sistema romano delle colonne reggenti l’architrave e dei pilastri che reggono gli archi, e il secondo (qui prevale la deroga manierista) che presenta balaustre discontinue, colonne sostenenti un ricchissimo fregio e serliane così contratte da annullare il loro valore di trifore.(fonte wikipedia).