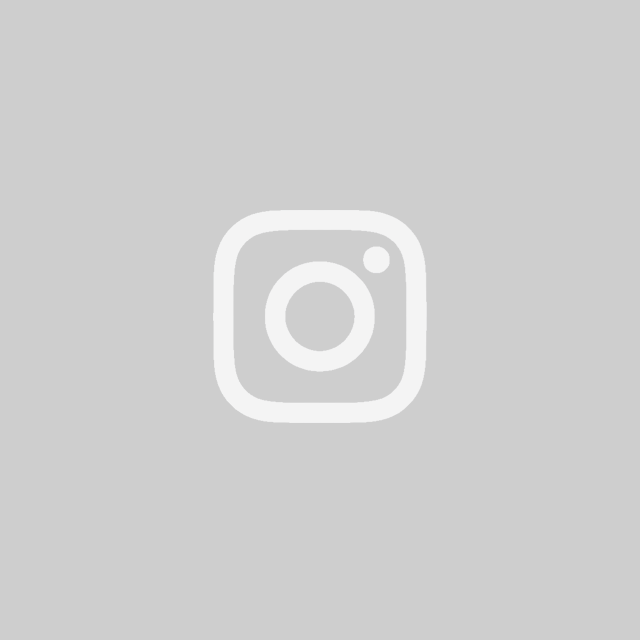La basilica di Santa Croce è una delle più grandi chiese officiate dai francescani e una delle massime realizzazioni del gotico in Italia. È nota come Tempio dell'Itale glorie per le numerose sepolture di sommi artisti, letterati e scienziati che racchiude. Nonostante sia una chiesa cattolica, vi sono anche sepolture di persone non credenti, come Ugo Foscolo. La prima personalità qui inumata fu Leonardo Bruni, mentre l'ultima persona sepolta effettivamente in Santa Croce fu Giovanni Gentile nel 1944, ma nel dopoguerra verranno apposte delle targhe commemorative, come quella per Enrico Fermi, la cui tomba si trova negli Stati Uniti dove morì nel 1954. Santa Croce è un simbolo prestigioso di Firenze, il luogo di incontro dei più grandi artisti, teologi, religiosi, letterati, umanisti e politici, che determinarono, nella buona e cattiva sorte, l'identità della città tardo-medievale e rinascimentale. Al suo interno trovarono inoltre ospitalità celebri personaggi della storia della Chiesa come san Bonaventura, Pietro di Giovanni Olivi, sant'Antonio da Padova, san Bernardino da Siena, san Ludovico d'Angiò. Fu anche luogo d'accoglienza per pontefici come Sisto IV, Eugenio IV, Leone X, Clemente XIV. STORIA: San Francesco visitò Firenze già nel 1211. Nel 1226-1228 un gruppo di suoi seguaci si stabilì in città, scengliendo una zona inospitale subito fuori le mura. Qui fornadorono un oratorio che, al crescere della comunità di frati, fu prima ingrandito e poi, dal 1252, completamente ristrutturato. La nuova chiesa si rese presto insufficiente, per cui nel 1294 si decise di ricostruire ex-novo l'edificio, con un grandioso progetto elaborato probabilmente da Arnolfo di Cambio. Fu edificata a spese della popolazione della Repubblica fiorentina. Alla morte di Arnolfo nel 1302 doveva essere completata la parte del coro e del transetto, con le cappelle. Procedendo con speditezza, i lavori nel 1320 resero la basilica utilizzabile, ma in seguito, le vicende della crisi, dell'alluvione e della peste, ne rallentarono vistosamente il completamento. Non si sa esattamente quando la basilica fu terminata, forse attorno al 1385. Fu comunque consacrata solo durante l'epifania del 1443 alla presenza di papa Eugenio IV. Il convento nacque praticamente in contemporanea alla basilica. Al nucleo iniziale si aggiunsero presto la sagrestia, il dormitorio, l'infermeria, la foresteria, il refettorio e la biblioteca. La basilica ha continuato ad essere arricchita e modificata dalla sua fondazione, acquisendo sempre nuovi connotati simbolici. Nel 1966 l'alluvione di Firenze inflisse gravissimi danni al complesso della basilica e del convento, situati nella parte più bassa di Firenze. ARCHITETTURA ESTERNA: La basilica è rialzata dal suolo di otto gradini. Originariamente la facciata era incompiuta, come in molte basiliche fiorentine. La parete di pietraforte a vista assomigliava molto a quello che ancora si vede a San Lorenzo, sebbene di forma e proporzioni diverse. La facciata odierna fu realizzata tra il 1853 e il 1863 ad opera dell'architetto Niccolò Matas, che si ispirò alle grandi cattedrali gotiche come il duomo di Siena e il duomo di Orvieto, rivisti alla luce della sua epoca. Il risultato finale venne aspramente criticato, ed è tutt'oggi controverso per il suo artificioso stile neogotico; tuttavia alcuni studiosi ne evidenziano la semplicità e il carattere umile. Tra le opere d'arte che appaiono sulla facciata spiccano le tre lunette dei portali, che ricordano la leggenda della Vera Croce, alla quale la chiesa è dedicata: da sinistra sono il Ritrovamento della Croce, il Trionfo della Croce e la Visione di Costantino. Davanti al portale si trova la sepoltura di Matas. Inconfondibile è il profilo esterno della basilica, coi fianchi ritmati dai timpani triangolari delle false campate della navata. Su ciascun scomparto si apre un'alta bifora, mentre il paramento è in semplice pietraforte a vista, decorato solo da pluviali a forma di teste umane o leonine, oggi molto sciupati. Sul fianco sinistro è addossato alla basilica un porticato trecentesco, detto delle Pinzochere, che venne restaurato e ingrandito a metà dell'Ottocento. Un portico analogo si trova anche sul lato destro, affacciato sul Chiostro Grande. L'esile campanile risale solo al 1847-1865; anche qui, come per la facciata, il progetto quattrocentesco, affidato a Baccio Bandinelli, si era risolto in un niente di fatto. La realizzazione ottocentesca viene giudicata generalmente come abbastanza graziosa per la sua defilata semplicità, anche se la decorazione con la ghiera sulla cuspide rivela l'ispirazione eclettica moderna. La struttura raggiunge un'altezza totale di 78,45 m. Sulla sinistra del sagrato fu collocato il monumento a Dante, a conclusione delle celebrazioni dantesche del 1865 per il VI centenario della nascita del grande poeta. Alla presenza di Re Vittorio Emanuele II fu inaugurata al centro della Piazza, ma venne in seguito spostata nel 1968. L'alto piedistallo è decorato da leoni marzocchi e dagli stemmi delle città italiane. ARCHITETTURA INTERNA: L'interno di Santa Croce è apparentemente semplice e altamente monumentale al tempo stesso, con tre navate divise da due file di grandi pilastri a base ottagonale. L'interno, ampio e solenne, ha una forma di croce a T, con un transetto particolarmente esteso che taglia la chiesa all'altezza dell'abside poligonale. Anticamente il transetto, dalla quinta campata in poi, era destinato ai soli presbiteri, con un tramezzo che separava questa area da quella per i fedeli e che venne rimosso, come in moltissime altre chiese, dopo le disposizioni del Concilio di Trento. Nella grandiosa navata centrale i muri sono sottilissimi, sostenuti da archi a sesto acuto su pilastri ottagonali, e richiamano le basiliche paleocristiane di Roma dove Arnolfo lavorò a lungo. In particolare il ballatoio che corona le arcate e cinge la navata centrale costituisce un legamento strutturale per tenere assieme le esili membrature e i vasti specchi murari. Il soffitto a capriate richiese un complicato congegno strutturale data l'enorme luce libera e il peso che rischiava di soverchiare le sottili murature. Arnolfo, rispettando in qualche modo lo spirito francescano, disegnò una chiesa con una pianta volutamente spoglia, con ampie aperture destinate all'illuminazione delle pareti sulle quali dovevano essere affrescati grandi cicli figurativi destinati a narrare al popolo analfabeta le Sacre scritture (la cosiddetta Bibbia dei Poveri). La grande chiesa ospita ben undici cappelle, più altre cinque dislocate alle estremità del transetto. Queste cappelle erano destinate alle sepolture dei donatori e ricevettero ricchissime decorazioni murali per mano dei maggiori maestri dell'epoca. Le navate sono rischiarate da numerose vetrate, spesso risalenti al Tre e Quattrocento. La basilica custodisce innumerevoli tombe. Solo sul pavimento sono disseminate 276 lastre di marmo con rilievi e stemmi intarsiati e molti monumenti funebri si trovano sulle pareti tra gli altari vasariani (molte di uomini illustri). Sebbene la basilica fosse stata usata come luogo di sepoltura di molti personaggi illustri, al pari di molte altre chiese, è solo nell'Ottocento che diventò un vero e proprio pantheon di personaggi celebri legati all'arte, alla musica e alla letteratura. Nel 1871 infatti veniva qui sepolto con una affollatissima cerimonia pubblica Ugo Foscolo, morto nel 1827, secondo il suo stesso desiderio di essere sepolto accanto ad altri grandi personaggi toscani come Michelangelo e Galileo. Dopo questo episodio iniziarono ad arrivare altre salme di celebrità decedute anche molti anni prima, come Gioachino Rossini nel 1887, Leon Battista Alberti, Vittorio Alfieri, eccetera, per i quali i migliori scultori dell'epoca realizzarono i monumenti che ancora si allineano nella navata. Anche per Dante fu approntato un grande sepolcro, ma la città di Ravenna si rifiutò strenuamente di consegnare le spoglie del poeta morto in esilio. Santa Croce arrivò ad ospitare quindicimila salme, con una grande mole di richieste da tutta Italia. CHIOSTRO: Il chiostro trecentesco si trova sul lato destro della facciata della Basilica e introduce alla Cappella Pazzi. Era originariamente composto da due chiostri distinti, uno rettangolare ed uno quadrato, che si possono individuare chiaramente nell'asimmetrica pianta attuale. CAPPELLA PAZZI: La Cappella dei Pazzi è un capolavoro di Filippo Brunelleschi e di tutta l'architettura rinascimentale, mirabile esempio di armonia spaziale raggiunta in tutti i suoi elementi strutturali e decorativi. Il portichetto della facciata è da alcuni attribuito alla continuazione di Giuliano da Sangallo, ma altri invece lo fanno risalire ai disegni del maestro. La volta a botte è decorata da tondi e rosoncini di Luca della Robbia, autore anche della lunetta sull'ingresso. All'interno la decorazione plastica è strettamente subordinata all'architettura, coi dodici grandi medaglioni degli Apostoli, tra le migliori creazioni di Luca della Robbia, il fregio coi Cherubini e l'Agnello, e gli altri 4 tondi policromi con gli Evangelisti, attribuiti a Andrea della Robbia o al Brunelleschi stesso che ne avrebbe curato il disegno. Sul chiostro si affaccia la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, che usa gli ambienti al primo piano sui lati sud ed est. (Fonte: Wikipedia)
Itinerari In Italia Twitter
Instagram Preview