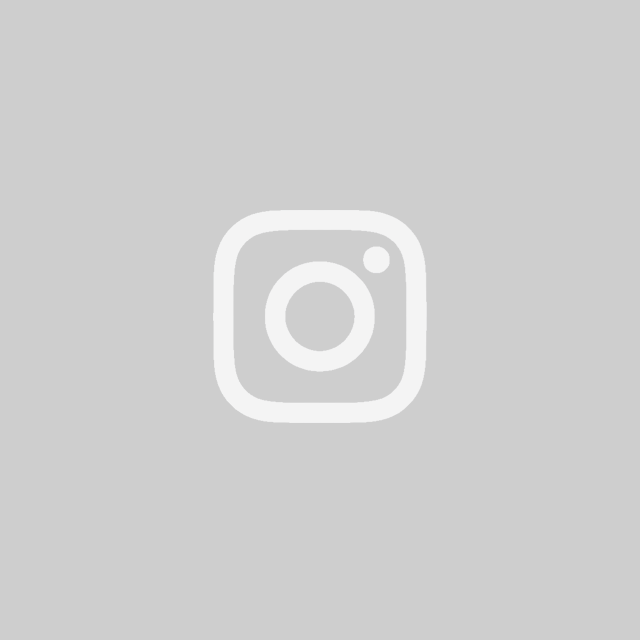La Basilica di San Michele Maggiore a Pavia è un capolavoro di stile romanico lombardo, risalente ai secoli XI e XII.
Una prima chiesa dedicata a San Michele Arcangelo fu costruita originariamente nel periodo longobardo grazie anche ai monaci di san Colombano di Bobbio, ma fu distrutta da un incendio nel 1004. La costruzione attuale iniziò verso la fine dell’XI secolo e fu completata nel 1155. Le volte della navata centrale, originariamente dotata di due campate a crociera grossolanamente quadrate, furono ricostruite nel 1489 da Agostino da Candia, con uno schema di quattro campate rettangolari, tali da garantire una migliore efficienza statica del complesso architettonico.
La Basilica di San Michele è considerata il prototipo delle numerose chiese medievali che può vantare Pavia. Tuttavia, si discosta dalle altre chiese cittadine per l’utilizzo estensivo, sia per quanto riguarda la struttura che le decorazioni, della fragile pietra arenaria color ocra in luogo del cotto, e anche per la particolare conformazione architettonica, che prevede una pianta a croce latina, con un transetto eccezionalmente sviluppato, molto sporgente rispetto al corpo longitudinale del fabbricato. Tale transetto, dotato di una propria facciata sul lato settentrionale, di una propria finta abside nel lato opposto e di una volta a botte sostanzialmente diversa dalle volte a crociera delle restanti parti della chiesa, costituisce quasi un corpo autonomo, una seconda chiesa compenetrata a quella principale: una soluzione inedita per quei tempi.
Le dimensioni della basilica, lunga 55 metri e larga al transetto 38 metri, evidenziano l’importanza di questa parte della struttura. All’incrocio tra navata e transetto si alza l’ardita cupola ottagonale su pennacchi di tipo lombardo.
La pianta a croce latina presenta una suddivisione in tre navate, a ciascuna delle quali corrisponde un portone sulla facciata. La navata centrale è larga il doppio delle laterali ed è divisa in due campate (quelle laterali in quattro), comprese da volte a crociera con costoloni, sorrette da possenti pilastri. Le navate laterali sono sovrastate da matronei, che, oltre ad avere una funzione formale, svolgono un preciso compito statico: creare cioè forze laterali che si contrappongano e arginino la pressione delle volte della navata centrale. Le quattro cappelle rettangolari che si aprono a coppie, in corrispondenza della seconda e terza campata delle navate laterali, sono un’aggiunta molto più tarda. Sotto l’abside, che presenta un grande affresco cinquecentesco, troviamo l’altare risalente al 1383. Sotto di esso si apre la cripta. I muri sono molto solidi, soprattutto all’esterno, rinforzati da contrafforti in muratura che respingono la pressione delle volte.
La facciata presenta un lineare profilo a capanna del tipo “a vento” (cioè più alta del tetto della navata centrale), impreziosito lungo gli spioventi da una loggetta di ventuno arcatelle. I contrafforti sono costituiti da pilastri a fascio che scandiscono verticalmente la superficie. La facciata è adornata con un folto repertorio di sculture di arenaria, a tema sacro ma anche profano, di grande bellezza e suggestione, ma oggi vistosamente deteriorate dalla corrosione dovuta agli agenti atmosferici, nonostante i numerosi programmi di restauro conservativo avviati negli ultimi decenni. Sulla facciata si aprono cinque piccole bifore, tre monofore e una croce compresa tra due occhi di bue. Tale disposizione è una ricostruzione ottocentesca: fino a quel periodo, era presente infatti un grosso finestrone circolare, certamente non originale, eliminato appunto per riportare la facciata alla configurazione originaria. Vi sono fasce orizzontali scolpite a bassorilievo, raffiguranti intrecci di esseri umani, animali e creature mostruose.